Terre Gaste
That grows to seed; things rank and
gross in nature
it merely.
È solo un giardino non sarchiato
che va in seme; e piante putrefatte e
volgari
tutte lo posseggono.
Atto 1 Sc. II p. 56
Questo
brano è tratto da un giudizio espresso da Amleto nei riguardi del suo paese,
ormai somigliante a quella che nei romanzi del Ciclo del Graal viene chiamata “Terre gaste”. Si tratta di una sorta di
maledizione suscitata da un pesante turbamento dell’ordine quale un’ingiusta
detronizzazione con conseguente salita al potere di un usurpatore.
Nell’estratto seguente se ne fa menzione:
« Madonna », rispose Parsifal, « mi pare, a sentire ciò che dite dei miei fratelli, che voi sappiate bene chi sono ». « Lo so », ella rispose, « e devo ben saperlo poiché sono vostra zia e voi mio nipote. Non dubitate vedendomi in questo luogo così povero e sappiate che sono colei che una volta veniva chiamata la regina della Terra Desolata. Voi mi vedeste in altre condizioni, quando ero una delle dame più ricche del mondo. Eppure quella ricchezza non mi piacque mai tanto quanto la povertà in cui mi trovo adesso ».[1]
La
disgrazia si abbatte, nel caso del Re Pescatore o Re Vulnerato del ciclo
arturiano, perché a causa delle sue mancanze il monarca subisce una menomazione
che, data la sua posizione centrale, si riflette nella terra che dovrebbe
governare.
Si tratta dell’accezione negativa
dell’“azione di presenza” che dovrebbe garantire il mantenimento dell’armonia
nel paese governato da chi si mantiene in equilibrio nell’“Invariabile mezzo”
come l’Imperatore cinese nel Ming-Tang.[4] Per
raggiungere una condizione ottimale di armonia questa orazione veniva
pronunciata alla fondazione della città di Lo-yang:
Possa il Re giungere e assumersi la
responsabilità per il lavoro del Signore Supremo (Shang Ti) e lui stesso
servire [con queste funzioni al centro del paese. Io, Tan, dico che, dopo aver
costruito questa grande città e da lì governando, egli sarà una immagine del
Cielo sublime. Egli, attento, offrirò sacrifici al superiore e all’inferiore, e
da lì governerà come il perno centrale.[5]
Saturno, oggi visto nel suo aspetto
malefico, simboleggiato dalla sua affinità con il piombo, materiale oscuro e
tendente verso il basso, “corrisponde in effetti alla più
elevata delle sfere planetarie, il “settimo cielo” o il Satya-Loka della tradizione indù”,
e fu il reggente dell’Età dell’Oro, il Satya
Yuga.[8]
Infatti,
da una prospettiva più elevata, “Non si
deve […] considerare Saturno unicamente, e neppure in primo luogo, una potenza
malefica, come sembra si tenda a fare talvolta, perché non bisogna dimenticare
che egli è innanzi tutto il reggente dell’‘età dell’oro’, cioè del Satya-Yuga o
della prima fase del Manvantara, che coincide precisamente con il periodo
iperboreo, il che dimostra come non senza ragione Kronos sia identificato col
dio degli iperborei. È verosimile del resto che l’aspetto malefico risulti qui
dalla scomparsa stessa di tale mondo iperboreo; in virtù di un analogo
‘rivolgimento’ ogni ‘Terra degli dèi’, sede di un centro spirituale, diventa
una ‘Terra dei Morti’ quando il centro è scomparso.” [9]
18
Caduta di Babilonia: lamenti sulla Terra e gioia nei cieli. – 1E dopo queste cose, vidi
scendere dal cielo un altro Angelo, con grande potenza, e la terra fu
illuminata dal suo splendore. 2Egli gridò con voce potente: “È
caduta, è caduta la grande Babilonia! È diventata la dimora dei demoni, il covo
di ogni spirito impuro, il rifugio d'ogni uccello immondo e odioso, 3perché
tutte le genti han bevuto il vino della sua frenetica lussuria e i re della
terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti per
l’esorbitante suo lusso!”
Dall’analisi linguistica risulta inoltre che: “… Altro nome degno di nota è quello di Babilonia: Bab-Ilu significa “porta del Cielo”, che è una delle qualifiche attribuite da Giacobbe a Luz; tale nome, d’altra parte, può avere anche il significato di “casa di Dio”, come Beith-El; diviene però sinonimo di “confusione” (Babel) allorché la tradizione è perduta: si verifica allora il rovesciamento del simbolo, e la Janua Inferni prende il posto della Janua Coeli.”[10]
Da “Porta del
Cielo” si passa a “Porta dell’Inferno”
destinata a dare adito al Caput mortuum
nella fase finale dell’Opera alchemica, con espulsione nelle “tenebre esteriori”.
Franco Galletti porta l’esempio di Creta
nella Divina Commedia, in cui il senso dell’andamento ciclico delle vicende
umane è reso anche dalla statua del “Veglio”:[11]
Nel
cammino inverso rispetto a quello ciclico, che dev’essere percorso da chi
persegue la realizzazione spirituale, si passa da una landa sterile e orrifica …
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura! (Inf. I, 5,6)
la divina foresta spessa e viva (Purg. XXVIII, 2)
Dante, nel sesto esempio di superbia punita raffigurato sul pavimento del primo girone del Purgatorio, si riferisce a Saul, ucciso insieme ai tre figli sui monti di Gelboe, in Palestina.
O Saùl, come in su la propria spada
quivi parevi morto in Gelböe,
che poi non sentì pioggia né rugiada! (Pg. XII,
41)
Sia la pioggia che la rugiada[13]
sono simboli degli influssi celesti che, se negati, comportano l’aridità e la
mancanza di frutti.
“La
viriditas - disperazione dei traduttori - , la “verdezza”, è nel cuore stesso
dell’universo nello schema cosmico di Ildegarda […] Il mondo al culmine della
primavera è pieno di viriditas, Dio ha dato il soffio della viriditas a tutti
gli abitanti del Giardino dell’Eden, anche il più piccolo ramo del più
insignificante degli alberi è animato dalla viriditas, il sole porta la vita della
viriditas al mondo; e (nel regno spirituale) il prelato pieno [di debolezza] è
carente in viriditas, il giardino dove crescono le virtù è imbevuto di
viriditas, il neofita deve battersi per avere la viriditas, e la Santa Vergine
è la viridissima virga …”[15]
Anche nell’Islam una terra desolata può
ritornare fertile: “L’Imam Bukhari riporta nel Libro
dei Profeti che il Profeta disse, "Al-Khidr[16] ('l’Uomo
Verde') era così chiamato perché una volta sedeva su una terra arida e bianca,
dopo ciò questa terra diventò di un verde lussureggiante di vegetazione.”[17]
Si rallegrino il deserto e la terra
arida,
esulti e fiorisca la steppa.
Come fiore di narciso 2fiorisca;
sì, canti con gioia e con giubilo.
Le è data la gloria del Libano,
lo splendore del Carmelo e di Saron.
Essi vedranno la gloria del Signore,
la magnificenza del nostro Dio. (Is
35, 1-2)
La
rispondenza tra l’interiorità dell’uomo e l’ambiente esterno è indicata con
chiarezza e ineccepibile progressione da questa citazione di Confucio, che si
riferisce a chi ha responsabilità di comando:
Poiché abbiamo parlato di «mandato celeste»,
non ci sembra fuori luogo riferire come, secondo lo stesso Confucio, tale
mandato dovesse essere adempiuto: «Per far risplendere le virtù naturali nel
cuore di tutti gli uomini, gli antichi principi si adoperavano prima di tutto a
ben governare ciascuno il proprio principato. Per ben governare il loro
principato essi mettevano prima di tutto il buon ordine nelle loro famiglie.
Per mettere il buon ordine nelle loro famiglie, lavoravano prima di tutto a
perfezionare se stessi. Per perfezionare se stessi, disciplinavano prima di
tutto i battiti del loro cuore. Per disciplinare i battiti del loro cuore,
rendevano perfetta innanzi tutto la loro volontà. Per rendere perfetta la loro
volontà, sviluppavano il più possibile le loro conoscenze. Le conoscenze si
sviluppano penetrando la natura delle cose. Penetrata la natura delle cose, le
conoscenze raggiungono il loro grado più elevato. Quando le conoscenze sono
arrivate al loro grado più elevato, la volontà diventa perfetta. Perfetta la
volontà, i battiti del cuore diventano regolari. Regolati ì battiti del cuore,
l’uomo tutto è privo di difetti. Dopo aver corretto se stessi, si stabilisce
l’ordine nella famiglia. Posto ordine nella famiglia, il principato è ben
governato. Ben governato il principato, presto tutto l’impero fruisce della
pace». n.1 Ta-hio, parte I. [20]
Medice,
cura te ipsum!
BIBLIOGRAFIA
·
Ciampi
E., William Shakespeare Pescatore di
uomini, Intento, Roma 2014.
·
Eliade
M., L’isola di Euthanasius, Bollati Boringhieri,
Torino 2000.
·
D’Anna
N., Il Santo Graal – Mito e realtà, Archè
– PiZeta, San Donato 2009.
·
Polia
M., Il Mistero Imperiale del Graal,
Il Cerchio, Rimini 2007.
· Granet
M., La pensée chinoise, Albin Michel,
Paris 1969; trad. it. Il pensiero cinese,
Adelphi, Milano 1971.
·
La
Cola F., San Giorgio – Il cavaliere
universale, Irfan, San Demetrio Corone 2018.
·
Salvadori
S., Hildegard Von Bingen – Nel cuore di
Dio, Skira, Milano 2021.
SITOGRAFIA
Il brano
sarà pubblicato sul secondo volume degli Atti dell’Accademia della Pigna,
Sanremo.
[1] A. Rosso Cattabiani (traduttrice), La Cerca del Santo Graal, Milano 1974, p.69.
[2] “Più il
sole dà, più il cielo pare alto e sorprendente e l’orizzonte vasto e prfondo:
mentre ciò che si trova nelle immediate vicinanze diventa neutro e ristretto.”
Abdul-Hâdi, Pagine dedicate al Sole,
in Rivista di Studi Tradizionali, Torino,
n. 14 Gennaio-Marzo 1965, p. 27.
[3] R. Guénon, Aperçus sur
l’Ésotérisme islamique et le Taoïsme, Gallimard, Paris 1973: trad. it. Scritti
sull’esoterismo islamico e il Taoismo, Adelphi, Milano 1993, p. 43.
[4] Id., La Grande Triade, Gallimard, Paris 1957; trad. it. La Grande Triade, Adelphi, Milano 1980, p. 123.
[5] Wen-Wang yu sheng, p. 430 in A.
Snodgrass, Architettura, Tempo, Eternità,
Bruno Mondadori, Milano 2004, p. 311.
[6] R. Guénon, Le Regne de la Quantité et les signes des
temps, Paris 1945; trad. it. Il Regno
della Quantità e i segni dei tempi, Adelphi, Milano 2009, p. 185.
[7] Si pensi al
“riutilizzo” e di luoghi e di materiali nei secoli di espansione del
Cristianesimo.
[8] Id., Symboles de la Science sacrée, Paris
1962; trad. it. Simboli della Scienza
sacra, Adelphi, Milano 1997, p. 137.
[9] Id., Symboles cit., p. 170.
[10] Id., Le Roi du Monde, Gallimard, Paris 1958; trad. it. Il
Re del Mondo, Adelphi, Milano p. 103 in nota.
[11] F. Galletti, La bella veste della Verità, Mimesis,
Milano 2020, p. 294.
[12] Sul
simbolismo del Veglio di Creta e i fiumi che ne scaturiscono v. G. Marano, Dante e il poema dell’acqua, Agorà &
Co., Sarzana-Lugano 2021, pp. 12 ss..
[13] «Dio ti conceda
rugiada del cielo e terre grasse e abbondanza di frumento e di mosto» (Gn
27, 28) e 2Sam 1, 21-22.
[15] A. H. King-Lenzmeier, Ildegarda di Bingen - La vita
e l’opera, Gribaudi, Milano 2004, p. 33.
[16] El-Khidr
è la designazione data dall’esoterismo islamico al personaggio anonimo menzionato
dal Corano nella sura XVIII (sura della Caverna) e con il quale Mosé, che pure
viene considerato dall’Islâm come inviato legiferante e «Polo» della sua epoca,
appare in rapporto di subordinazione. Tale subordinazione sembra sia tanto
d’ordine gerarchico quanto conoscitivo, poiché il personaggio misterioso è
presentato come detentore della scienza più trascendente (letteralmente: «la
scienza che viene da Noi», cioè Allâh), e Mosé domanda al suddetto personaggio
soltanto di insegnargli una «porzione» dell’insegnamento di cui è detentore. [Nota
di Jean Reyor] R. Guénon, Initiation et
réalisation spirituelle, Èditions Traditionnelles, Paris 1952; trad. it. Iniziazione e realizzazione spirituale,
Edizioni Studi Tradizionali, Torino 1967, p. 286.
[17] https://www.sufi.it/sufismo/maestri/al-Khidr.asp
V. inoltre A. K. Coomaraswamy, Khwâjâ Khadir e la fontana della vita, Rivista di studi
Tradizionali, n. 20-21, Torino 1966, p. 133.
[18] Gn. 17, 19 e
21, 3.
[19] Lc. 1, 13 ss..
[20] R. Guénon, Autorité Spirituelle et Pouvoir Temporel, éd. Guy Trédaniel, Éditions Véga, Paris 1964; trad. it. Autorità
spirituale e potere temporale, Luni, Milano 1995, p. 40.
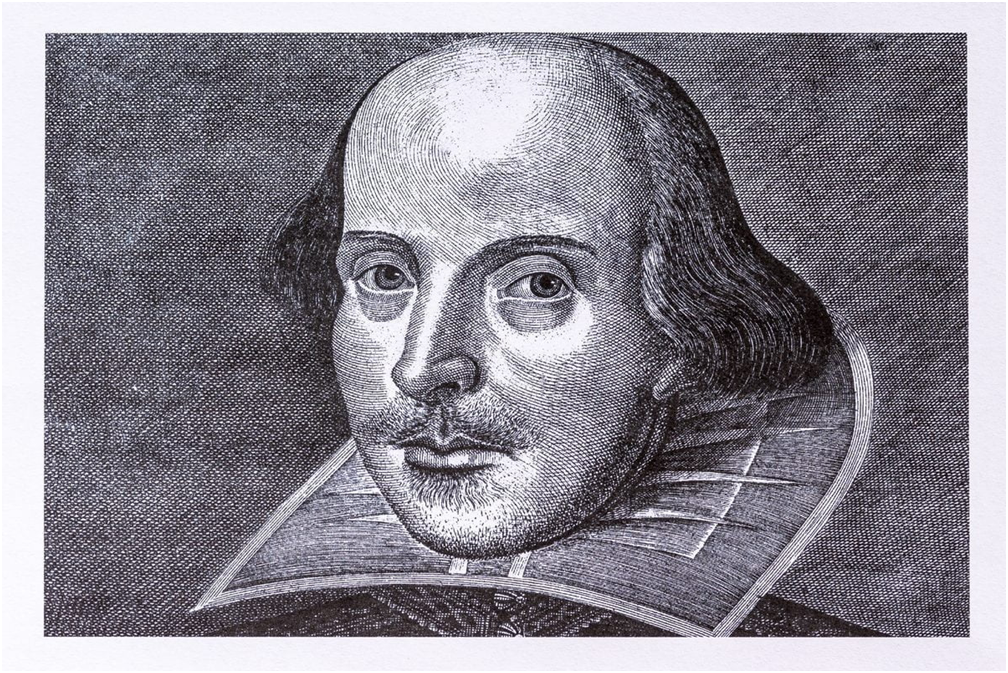


Commenti
Posta un commento